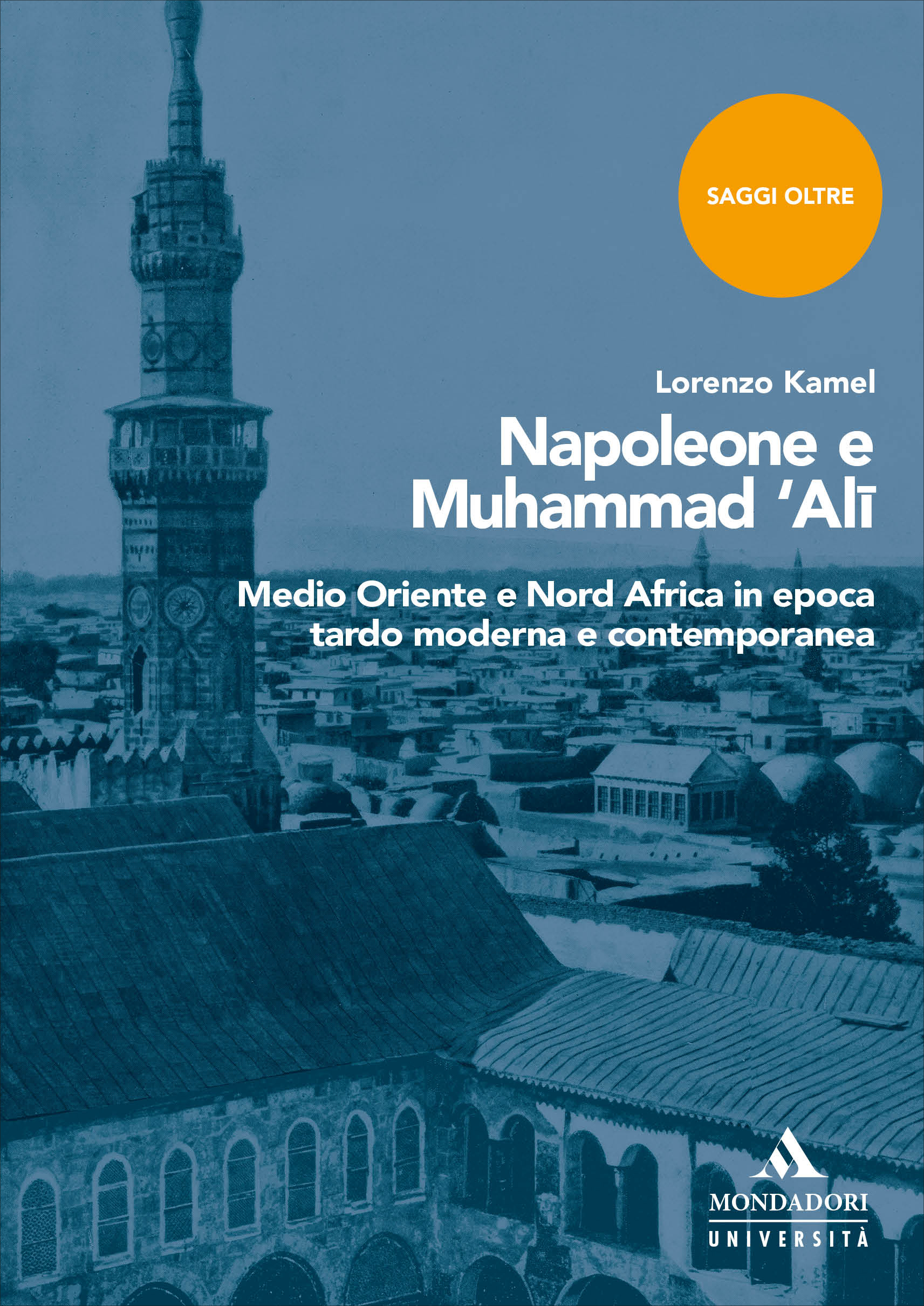Un libro che racconta nuovi equilibri globali in un momento sono così delicati e importanti da comprendere, per il presente e il futuro che sarà. Ne parliamo con Lorenzo Kamel, professore associato di Storia contemporanea all’Università di Torino e direttore delle collane editoriali dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), che ha scritto un libro dal titolo molto originale “Napoleone e Muhammad ‘Ali. Medio Oriente e Nord Africa in epoca tardo moderna e contemporanea”.
Professor Kamel, da dove nasce il titolo di questa pubblicazione?
Figure come Napoleone e Muhammad ῾Alī mi hanno permesso di fare luce su come troppo spesso si tenda a soffermarsi sui fenomeni di rottura, come ad esempio le rivoluzioni o le invasioni, a scapito delle continuità storiche. Nel libro ho applicato la dicotomia tra continuità e rotture storiche anche, ad esempio, in relazione ai processi riformisti e ai movimenti proattivi propri del Medio Oriente e del Nord Africa. Spesso si pensa infatti che i movimenti riformisti siano da sempre quasi solamente riconducibili a una reazione all’influenza dell’Occidente. In realtà, ben prima dell’avvento dei colonialismi europei, larga parte di questa enorme area del mondo fu infatti interessata da molteplici fenomeni riformisti e da nuove spinte proattive – dunque non reattive – di carattere religioso, sociale e culturale. Si pensi al movimento di “ricostruzione morale” – legata al Tajdīd (rinnovamento religioso) – diffusosi in larga parte della regione nel corso del Settecento. O, per fare un altro esempio, al Wahābismo, il movimento riformista religioso che tanto ha contribuito a delineare l’identità saudita moderna: questi e molti altri possibili esempi erano in tutto per tutto indigeni, indipendentemente dal giudizio di merito che ne possiamo dare. Ciò non implica che in una fase successiva quegli stessi fenomeni – così come altri ad essi affini non abbiano effettivamente fatto registrare anche una significativa componente ‘reattiva’, dunque come reazione all’influenza esercitata nella regione dalle potenze europee, nonché come reazione alle innovazioni e alle cicatrici delle quali esse si fecero portatrici. Non dimentichiamo che fu l’Algeria del 1843, ad esempio, il primo caso in cui venne utilizzato dai francesi del fumo come arma per asfissiare migliaia di civili. O, ancora, che qualche decennio più tardi, fu sempre in Medio Oriente che venne registrato l’uso di armi chimiche per sterminare migliaia di esseri umani. Mi riferisco alla Terza Battaglia di Gaza del 1917, quando le truppe guidate dal generale inglese Allenby utilizzarono circa 10.000 granate cariche di gas asfissiante per uccidere chi si trovavano di fronte. Dunque è chiaro che si è verificata anche una componente reattiva – ben visibile in decine di movimenti come la confraternita della Sanūsiyya, affermatasi a partire dal 1837 nell’area dell’odierna Libia, e il Mahdismo in Sudan – non ultimo in relazione a queste cicatrici della storia. Ma soffermarsi solo o soprattutto sulle spinte reazionarie a scapito dei movimenti proattivi è parte integrante di ciò che John Hobson ha definito “la violenza epistemica”, ovvero il processo attraverso cui figure, popoli e contesti non-occidentali sono stati sovente “silenziati”, o descritti come passivi.
Qual è stata la principale cesura nella storia del Medio Oriente e del Nord africa?
Quella legata al primo conflitto mondiale. Fu infatti solo a seguito delle guerre balcaniche (1912), del genocidio armeno (1915-6) e dell’accordo siglato a Losanna nel 1923 tra la Turchia e le potenze dell’Intesa che la “razializzazione delle identità” – ovvero la tendenza ad ascrivere un profilo genetico immutabile ad un dato gruppo – e la loro selettiva etno-confessionalizzazione, acquisirono la loro forma attuale. Fu sempre allora che concetti come “trasferimento di popolazione” e “pulizia etnica” divennero, per la prima volta nella storia, delle soluzioni legalmente accettabili per risolvere dei conflitti internazionali. Lo “zeitgeist di Losanna” ha coinciso in altre parole con il primo grande fenomeno di rottura nella storia della regione e ha cambiato per sempre le percezioni – e il modo di auto-percepirsi – dei suoi abitanti, favorendo l’ascesa di identità chiuse e sigillate che hanno scandito anche e soprattutto questa parte del mondo in questi ultimi anni.
Da dove l’esigenza di analizzare questioni medio orientali e nord africane rispetto alle questioni di più stretta attualità?
In Medio Oriente, culla di civiltà millenarie, si concentra il 63 percento dei giacimenti petroliferi mondiali, il 30 percento del commercio globale e il 48 percento dei siti patrimonio dell’umanità. Rappresenta inoltre uno dei principali centri globali legati al turismo e ai flussi migratori: un aspetto ancora più significativo se si pensa che la popolazione del Nord Africa e del Medio Oriente aumenterà di almeno un terzo da qui al 2050. Ognuno di questi aspetti è parte di una più ampia e complessa ‘struttura’ che, in modi e forme differenti, continuerà a riecheggiare anche in Europa e in diversi altri angoli del mondo. D’altronde, come ha più volte insegnato la storia, ciò che inizia in Medio Oriente non rimane in Medio Oriente.
In che modo i fenomeni che riguardano quella porzione di mondo impattano sulle nuove generazioni?
L’età media della popolazione dello Yemen è 18,4 anni. 21 quella in Iraq, 20 in Sudan, 29 in Marocco e 32 in Iran. Questi pochi esempi ci ricordano l’enorme vitalità e il potenziale di questi contesti, ma anche le grandi sfide legate al mercato del lavoro, ai servizi e all’impatto sul clima e sulle risorse naturali. Anche l’Europa è chiamata a giocare un ruolo più costruttivo per rendere queste sfide affrontabili, se non altro per limitare i flussi migratori temuti da larga parte dell’opinione pubblica dei nostri paesi. Si pensi ad esempio al fatto che la quasi totalità degli apparecchi elettronici che vengono gettati in Europa finiscono in discariche dislocate in Africa e in Medio Oriente, contribuendo ad avvelenare – attraverso il rilascio di arsenico, mercurio e altre sostanze tossiche – il suolo e l’acqua utilizzati da milioni di essere umani. A ciò si aggiunga che le risorse naturali – petrolio, oro, gas ecc. – presenti nella quasi totalità dei Paesi africani sono pilotati attraverso società off-shore che, in larga misura, sono collegate a imprese e uomini d’affari operanti in Europa e in America. Paesi come la Francia mantengono il completo controllo delle politiche monetarie di un ampio numero di Paesi africani: un sistema che li vincola a rimanere esclusivamente esportatori di materie prime. D’altro canto, ancora oggi il Medio Oriente e l’Africa vengono inondati di armi di fabbricazione occidentale, oltre che cinesi e russe. Molte delle risorse naturali presenti in questi contesti sono oggi sempre più drenate dall’economia civile verso quella militare: anche in questo caso diversi attori europei svolgono il ruolo di co-protagonisti nell’intero processo. Quando sentiamo invocare slogan come “non possiamo accoglierli tutti”, “difendiamo la nostra identità”, “aiutiamoli a casa loro”, “logica buonista”, dovremmo sempre includere nell’equazione il peso della Storia, passata e presente.
Nel mondo ci sono molti conflitti in corso, di cui spesso di smette di parlare. Oggi a tenere banco c’è chiaramente quello russo-ucraino. in estrema sintesi, quali processi attraversano le regioni geografiche che lei analizza in relazione al conflitto attualmente in corso?
L’Egitto, il Paese storicamente più influente e popoloso del mondo arabo, importa in media 800mila tonnellate di mais al mese. Al cambio attuale, le autorità egiziane hanno bisogno di mettere a bilancio un budget aggiuntivo di 600 milioni di dollari solo per il 2022. Un discorso simile può essere fatto per la farina, di cui la Russia è il maggior produttore a livello mondiale (24% del totale). Si tratta solo di due esempi, ma rendono l’idea dell’impatto che questa guerra sta già avendo sull’Egitto, la Libia, lo Yemen, il Libano e molti altri paesi. Vale forse la pena ricordare che le “rivolte arabe” sono scoppiate anche a causa di questioni molto pratiche, come il prezzo delle materie prime.
Quale il futuro degli equilibri medio orientali e con quali possibili conseguenze su quelli globali?
Il Medio Oriente è un’enorme area dai confini “ideali”, incerti e porosi, – che nella più comune accezione odierna si estende dal Marocco all’Afghanistan e dalla Siria al Sudan – che ha rappresentato da sempre un nevralgico punto di snodo per i traffici commerciali e culturali tra l’Asia e l’Europa. Tale ruolo strategico ha conosciuto un’accelerazione, per molti aspetti senza precedenti, nell’ultimo quarto del Novecento, grazie alla commistione di tre aspetti principali. Il primo riguarda le ripercussioni della crisi petrolifera del 1973-4 e il relativo incremento vertiginoso del prezzo del greggio: il punto di partenza di un trend che ha catalizzato il crescente interesse di attori extra-regionali per l’oro nero del Medio Oriente, dove si concentra per l’appunto il 63 percento dei giacimenti petroliferi mondiali. Il secondo aspetto è legato alla recrudescenza del conflitto arabo-palestinese-israeliano e alle sue ricadute politiche, economiche e sociali. Non meno determinanti, infine, furono i risvolti di medio termine della cosiddetta Rivoluzione iraniana del 1979, nonché l’ascesa e l’uso strumentale di ciò che da allora è noto in Occidente come fondamentalismo islamico. Questi e molti altri aspetti continueranno ad avere un impatto che andrà ben oltre la regione anche nei decenni a venire.
Qual è uno dei cliché più duri a morire riguardo la regione?
Esistono numerosi cliché legati al Medio Oriente, una delle regioni che più di ogni altra è stata, fin dall’antichità, raffigurata attraverso stereotipi e immagini semplificate e/o romanzate. Un cliché che ancora oggi mantiene una forte presa, tanto all’interno della regione quanto al di fuori di essa, riguarda il presunto ruolo remissivo o passivo rivestito dalle donne nei principali snodi legati alla storia moderna e contemporanea del Medio Oriente. Dalla documentazione analizzata nel mio libro emerge in più parti un dato sovente trascurato o minimizzato: molte delle rivoluzioni e delle lotte anti-coloniali che più hanno plasmato lo sviluppo del Medio Oriente e del Nord Africa sono state innescate e/o profondamente influenzate da figure di donne locali. Il massiccio sciopero organizzato nel dicembre 2006 alla fabbrica tessile di Ghazl Al-Mahalla, quando tremila donne marciarono per denunciare le condizioni in cui erano costrette a lavorare, rappresenta solo uno dei numerosi possibili esempi. “Le donne sono qui”, riportavano i cartelli esposti in quella e in altre occasioni, “dove sono gli uomini?”. Tale sciopero ha aperto la strada a decine di altre manifestazioni e all’ascesa di diversi gruppi di mobilitazione, incluso il movimento di protesta nazionale “6 aprile 2008”, in seguito ribattezzato Harakat Shabab 6 April (Il Movimento giovanile del 6 aprile). Tre anni più tardi questo stesso movimento ha avuto un ruolo rilevante nel determinare la fine politica del regime trentennale guidato da Hosni Mubarak.
Qual è la percezione in Medio Oriente e in Nord Africa della guerra in Ucraina?
Pur consapevoli che quella in corso in Ucraina sia un’invasione illegale e immorale, una percentuale significativa delle popolazioni del Medio Oriente e del resto dell’Asia ritengono, per citare Shivshankar Menon, che si tratti di una guerra combattuta per definire “l’ordine di sicurezza europeo – e non come una epocale conflagrazione globale”. Molti tra quanti sostengono questo punto di vista sono critici riguardo il sistema finanziario mondiale – il 95% delle riserve monetarie globali è detenuto in valute occidentali – e ritengono che i tempi siano maturi per un ripensamento delle relazioni internazionali e degli ordini globali.
Le guerre di questi ultimi due decenni hanno avuto un impatto sulle sensibilità legate al conflitto in Ucraina?
Certamente. Si pensi che l’aggressione dell’Iraq, dove oltre all’uranio impoverito sono state utilizzate bombe a frammentazione e al fosforo bianco, è costata la vita a quasi un milione di esseri umani. Nessuno è stato chiamato a rispondere dei crimini compiuti in Iraq, né vennero inviate armi agli aggrediti, o imposte sanzioni per fermare, o denunciare, l’aggressione. È opportuno ricordare che, come come ha confermato l’inchiesta commissionata nel 2009 dall’allora premier britannico Gordon Brown a sir John Chilcot, l’intervento in Iraq era “unnecessary”, le basi giuridiche per l’azione militare erano “lontane dall’essere soddisfacenti” e la principale giustificazione per l’attacco (le armi di distruzione di massa) era fondata su dati fallaci. L’allora presidente della commissione per le relazioni esterne del Senato degli Stati Uniti, Joe Biden, fu uno dei 77 senatori che dette a George W. Bush l’autorità per lanciare l’attacco. Al tempo, Biden ebbe la possibilità di selezionare tutti e 18 i testimoni nelle audizioni tenutasi al Senato sull’Iraq e scelse per questo compito principalmente esponenti favorevoli alla guerra. È lecito chiedersi se l’intervento abbia portato un qualche beneficio, o una sia pur limitata stabilizzazione della regione. Una possibile risposta è rintracciabile nei dati forniti dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, stando ai quali gli attacchi terroristici verificatisi tra l’inizio della “guerra al terrore” (2001) e il 2014 sono aumentati del 3800 per cento: la metà di essi sono avvenuti in Afghanistan e Iraq.